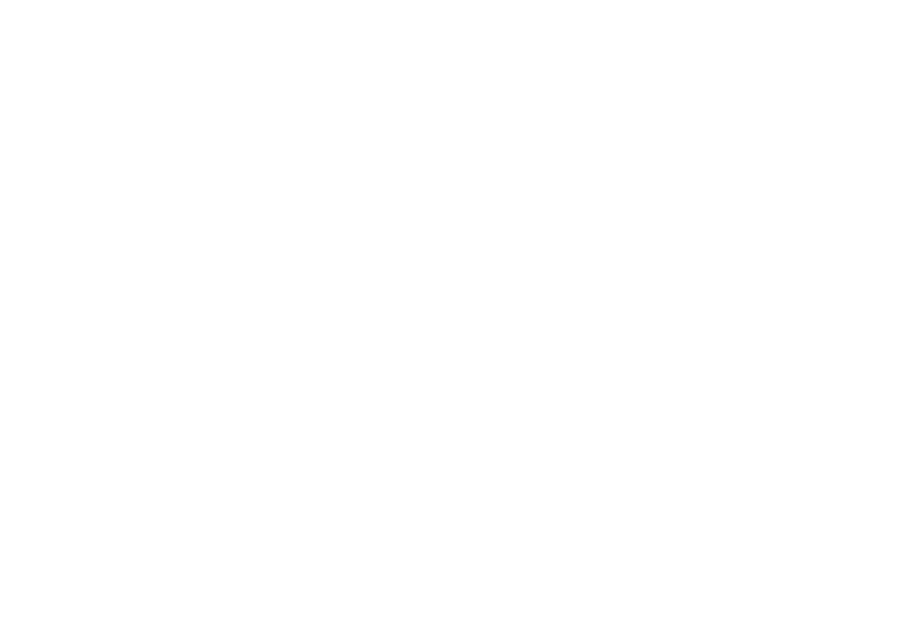ADD Editore 2013, pagine 191
Il libro inizia con il racconto dell’infanzia e della giovinezza di Rabhi. Siamo nel sud dell’Algeria quando il bambino guarda ammirato il padre fabbro che svolge il suo lavoro con orgoglio e soddisfazione. La vita nel piccolo villaggio si svolge tranquilla e frugale. È un mondo, che era fino ad allora in equilibrio, che di colpo viene spazzato via: gli occupanti francesi hanno scoperto un giacimento di carbone nel sottosuolo e impongono lo sfruttamento della miniera. Gli uomini liberi diventano servi e la modernità, arrogante e totalitaria, impone il denaro e la ricchezza come misure di benessere e di felicità.
Ci si sposta a Parigi, negli anni ’50, quando la fiducia in un futuro di felice progresso godeva la sua epoca d’oro. I lavoratori sognavano un avvenire luminoso per i figli ma questi cadono vittime di uno strano malessere: in un eccesso di “avere” essi avvertono una diminuzione dell’”essere”. Accanto a tutto ciò si assiste al declino progressivo del mondo contadino che provoca l’allontanamento dalla terra come madre comune per tutti.
Le guerre e il bisogno di manodopera per le industrie hanno contribuito a sradicare e a esiliare milioni di persone E anno causato una totale alienazione, tipica del mondo moderno.
Il ritorno di Pierre Rabhi alla terra, nel 1961, è problematico: i contadini che lui incontra sulle montagne dell’Ardeche francese sono molto diversi da quelli della sua infanzia in Algeria. Nella campagna ora si tessono le lodi della chimica (fertilizzanti, antiparassitari, pesticidi) e della tecnologia (trattori, mietitrici, trebbiatrici).
L’autore prova a chiedersi quale sia la causa di tale profondo cambiamento. A suo parere tutto deriva dal primato della ragione occidentale, un positivismo radicale nel quale prevale la specializzazione ma manca totalmente la sensibilità e l’intuizione. In più si sviluppa a dismisura l’informazione che diviene pervasiva e manipolatrice. Di fronte a questo prevalere della ragione e a questa invasione di notizie occorre fare di tanto in tanto una buona dieta attraverso il silenzio . Questo silenzio rappresenta un digiuno purificatore ed è uno degli atti di sobrietà più benefici.
La modernità ha assoggettato la bellezza e la nobiltà della natura e dell’anima umana alla volgarità della finanza. Il guadagno e l’accumulo portano alla smoderatezza: si perde il senso di sobrietà che aveva caratterizzato la vita di gran parte dell’umanità.
La sobrietà rappresenta una sorta di saggezza ancestrale che l’autore tenta di definire attraverso alcuni racconti di grande suggestione. La sobrietà sta anche nel riconoscere che nulla ci appartiene ma che, anzi, siamo noi ad appartenere alla terra; questo era stato compreso molto bene da alcune tribù indigene che uccidevano soltanto gli animali che necessitavano loro per vivere, chiedendo scusa alla natura per la violenza e non volendo assolutamente accumulare beni non necessari. Essi hanno fondato la loro società sulla moderazione e sulla frugalità che implicano anche collaborazione e ospitalità.
Quella che oggi chiamiamo economia è l’arte di fare della predazione una scienza complessa dimenticando la sacralità della vita
La sobrietà felice attiene alla sfera mistica e spirituale, senza certezze di verità. È necessario riequilibrare il rapporto tra il maschile e il femminile a favore di un femminile contrario alla violenza e più attento alla vita. È necessario mettere in atto una pedagogia dell’essere che recuperi la manualità, l’arte, l’agricoltura. Occorre sradicare dal profondo di noi stessi i germi dell’oppressione. Egli afferma “io non sono mai stato violento nelle mie proteste, ma non per questo ho indicato la passività, piuttosto una insurrezione delle coscienze”.