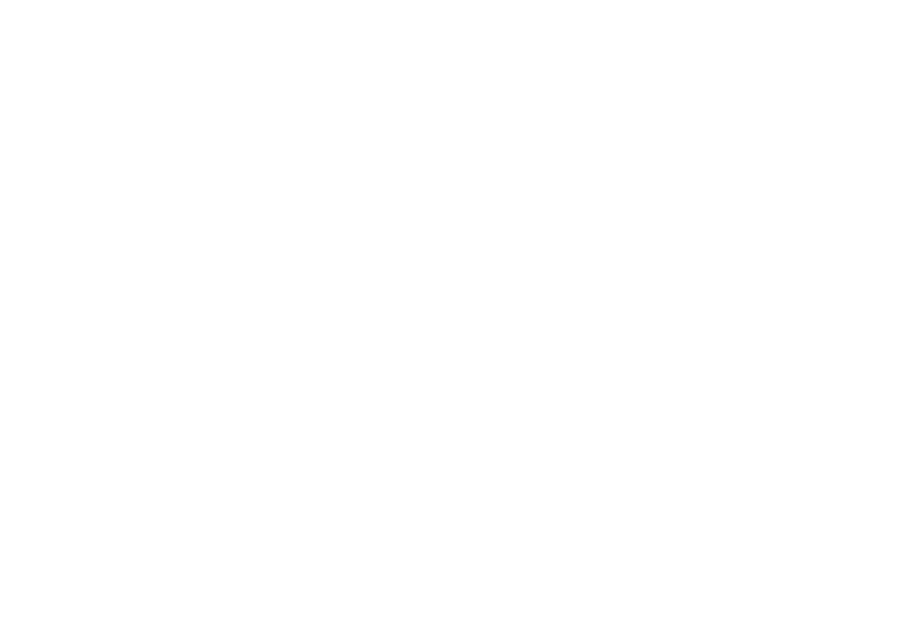Feltrinelli 2023, pp. 256
Aristotele distingueva due tipi di rivoluzione: nella prima gli inferiori si ribellano per essere uguali, nella seconda gli uguali si ribellano per essere superiori.Negli ultimi cinquant’anni il neoliberismo ha sviluppato e vinto una vera guerra contro i poveri. Sembra non ci sia stata alternativa: era una ‘rivoluzione invisibile’ che reagiva ai movimenti di sinistra degli anni ’60 e 70. Gli imprenditori, americani prima e mondiali in seguito, hanno capito che dovevano attuare una operazione di guerriglia per difendersi e hanno iniziato, attraverso l’opera delle fondazioni, a controllare le università, le televisioni, i media, la giustizia, e tutto questo alla luce del sole. La cultura si è trasformata in un bene di mercato e si è affermata l’idea che ogni persona sia, o debba essere, l’imprenditore di se stesso. In questo senso un povero è un imprenditore che ha lavorato male. Anche dal punto di vista della tutela ambientale il neoliberismo americano parla non tanto di eliminare l’inquinamento, ma di assicurare una qualità e quantità ottimale dell’inquinamento stesso.
L’idea base del neoliberismo è che non ci si possa aspettare nulla di buono dalla collettività, dallo stato, dal bene comune; e ciò va insegnato fin dall’infanzia. Quindi sono necessarie scuole private controllate, nelle quali si possano trasmettere queste idee. Le scuole pubbliche a poco a poco vengono impoverite e asservite.
A volte ci si può chiedere perché non scoppi la rabbia, la rivolta, una qualche risposta, nel comprendere l’estremo controllo a distanza e nel capire che una prospettiva verso il futuro appare sempre più difficile. I nostri dati e, quasi ormai, le nostre identità sono in mano a pochi privati, il debito tiene tutti sotto scacco.
Il debito è un mezzo di controllo potentissimo, che spegne la libertà e il desiderio di futuro, non solo dei singoli individui, ma di intere nazioni. In questo libro Marco d’Eramo compie una attenta analisi su come il debitore debba conformarsi alle direttive del creditore.
L’autore esamina, nella seconda parte del libro, la questione ambientale, concludendo con la constatazione che l’accelerazione verso la catastrofe è sempre più decisa; un rallentamento per il capitalismo significa la morte. Per questo non si deve parlare di decrescita o di sobrietà, concetti che mettono in dubbio la validità e l’infallibilità del mercato. Il danno ambientale viene smorzato e declassificato a debito da saldare in futuro, non è più visto come una tragedia presente. Secondo l’opinione di Marco d’Eramo occorre imparare dagli avversari, capire quali sono stati e sono i loro punti di forza e impegnarsi sullo stesso piano: il piano ideologico, quello della giustizia, quello dell’istruzione e quello del fisco.
Impegnarsi per salvare il mondo, pur in questa situazione che può apparire disperata, non è inutile.